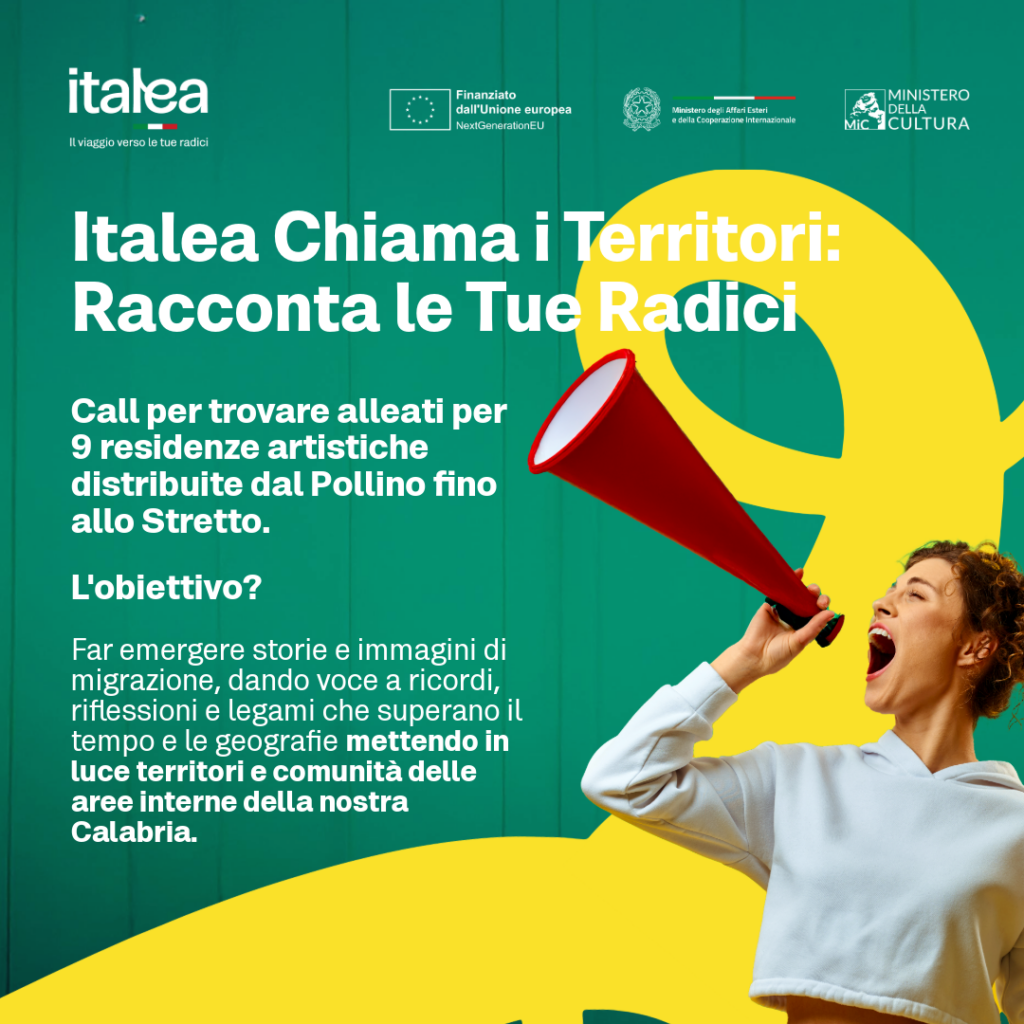All’interno del programma Italea Calabria (progetto sul Turismo delle Radici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), frutto di dieci residenze artistiche realizzate in diversi territori − dal Pollino allo Stretto − che hanno coinvolto tre drammaturghi e quattro artisti, S’amuJamu è un’esperienza immersiva sulla storia delle migrazioni in Calabria.
Un viaggio che parte dalla metà dell’Ottocento e arriva nel presente, lungo le rotte che hanno portato donne e uomini calabresi nel mondo e dall’altra parte del Mediterraneo verso le nostre coste. Il pubblico, munito di cuffie, si immerge nelle parole e nei racconti di oltre cento persone che hanno condiviso la loro storia di migrazione con gli autori Elvira Scorza, Dario Natale e Lorenzo Praticò e, accompagnati dalle musiche del compositore Davide Ambrogio, si muove in quattro “luoghi dell’anima”, caratterizzati dalle quattro installazioni di Ozge Sahin, Mariachiara Falcomatà, Luca Granato e Larissa Mollace: valigie di cartone ricamate da un filo fosforescente con l’invito a gustare del pane; girandole di falene sospese sulle teste dei “viaggiatori”; stendardi cuciti a mano che rappresentano nuove ideali mappe geografiche; e un tappeto stampato dal sole con i volti delle storie ascoltate.
Un’esperienza emotiva totale che fa immergere il pubblico nelle storie delle radici calabresi, di una terra che è sempre stata punto di partenza e di arrivo. S’amuJamu è la metafora di un viaggio, un invito all’andare.
Se hai già fatto l’esperienza e sei arrivato/a qui attraverso il QR code sulla cartolina, questo testo è per te.
S’amuJamu verbo andare – Resoconto del viaggio: tra le opere.
In questo viaggio, ogni installazione si è tramutata in un luogo dell’anima, dove chi vi si è immerso è divenuto viaggiatore migrante, pronto ad andare, guidato dalle voci degli autori e dai ritmi arcaici e ancestrali di Ambrogio.
Per il pane di Ozge Sahin è stata la prima tappa di questo cammino. L’artista, giocando sul significato e sulla funzione degli oggetti impiegati, ha elaborato una composizione scenica che assume la forma di una ritualità antica: la condivisione del pane. Attorno ad esso − simbolo della fame, che è causa di partenza e motivo di permanenza del migrante − erano disposte tre valigie nere, sulle quali si scorgevano frasi e figure pregne di evocazioni: Qui partiti, Fin qui arrivati, Resto intanto sogno; la figura di una Madonna e due immagini dell’arte magnogreca. Per Ozge la Vergine col cuore in mano è la metafora del sacrificio di chi resta; la sirena che regge una colomba rappresenta lo slancio di chi sta partendo; e l’Askos con sirena restituisce l’identità ibrida di chi è emigrato. Infatti, il nero di questi oggetti rimanda al lutto e al dolore che i migranti affrontano, lasciando la propria terra e i legami. Così, siamo stati invitati a prendere un pezzo di pane, affinché riflettessimo sulla migrazione come esperienza umana universale: talvolta dolorosa, altre volte meno, se condivisa con solidarietà, come il pane.
Si è proseguito verso Necessità di vita. Un’esistenza scritta sulle ali di Mariachiara Falcomatà, che ha esplorato il desiderio mimetico come componente dei processi antropologici. L’opera era una soglia costituita da due archi, dai quali pendevano girandole di falene, simili alla Biston Betularia Typica. La quale, per sopravvivenza, venne man mano sovrastata dalla sua variante melanica, la Carbonaria per adeguarsi agli ambienti industriali. La metamorfosi di questo insetto, legato all’avvento della modernità, evoca il bisogno umano di adattarsi alle esigenze sociali di un nuovo contesto. Contrastare pericoli e incognite di una nuova morfologia dei luoghi e delle società è stata anche una prerogativa delle popolazioni del nostro Sud nel secolo scorso. Il messaggio dell’artista è chiaro: il cambiamento per necessità è una fase vitale che non esclude nessuno, neanche le altre specie viventi.
Più avanti, siamo giunti dinanzi a Something about us di Luca Granato. Mediante il recupero di vecchi tessuti − donati da alcune famiglie o ritrovati all’interno di case abbandonate nel Sud Italia − egli ha indagato l’emigrazione, le dinamiche familiari, nonché le condizioni storiche e socioeconomiche del Meridione contemporaneo. L’artista ha cucito – richiamando l’antica tradizione del corredo − le trame mnemoniche degli stracci, degli abiti e delle coperte, rendendoli tre nuove bandiere colorate: echi di microstorie locali e testimoni di vite e comunità in costante trasformazione tra un continente e l’altro. Granato ha sottratto all’oblio tessuti lacerati dal tempo, emblemi di memoria intima e familiare, per tramutarli in un ricordo tangibile di questo viaggio.
All’ultima tappa si trovava L’orto di quelli che restano di Larissa Mollace: un lungo tappeto di cianotipie, con doppia esposizione, che riavvolge i ritratti delle persone incontrate durante le residenze e i luoghi da cui esse provenivano. La genesi di questo progetto è una riflessione personale dell’artista sulle conseguenze della migrazione, sulle ragioni che l’hanno alimentata e sul ruolo di coloro che restavano in quanto in possesso di un po’ di terra. L’orto, in questa visione, è un luogo di sopravvivenza e di radicamento. Secondo Larissa chi è restato, sebbene non si sia mai imbarcato su un aereo o non abbia viaggiato, è stato custode di un sapere prezioso che ha nutrito con il duro lavoro intere generazioni di calabresi. La tecnica utilizzata da Mollace è un richiamo ai processi di essicazione dei pomodori per le conserve sott’olio. Le cianotipie sono, infatti, impronte di assenza e di persistenza generate dall’esposizione alla luce naturale: la stessa che un tempo maturava i frutti negli orti dei pochi possidenti rimasti.
Il cammino è così volto al termine: tra la sacralità della memoria; tra la nostalgia di chi è andato e tornato; tra i racconti di chi, andando avanti, ha portato con sé il peso delle distanze. Tra le opere che si sono fatte esperienze del migrare, di cui la dignità è l’elemento fondante.